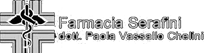Se i neuroni che formano l’area tegmentale ventrale, una delle principali zone del cervello in cui viene prodotta la dopamina, muoiono, ci si ammala di Alzheimer.
A rivelarlo uno studio dell’Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con Irccs Santa Lucia e Cnr.
La dopamina è un neurotrasmettitore indispensabile per il buon funzionamento dell’ippocampo, struttura cerebrale da cui dipende la memoria. Scoperto anche il legame tra l’assenza di dopamina e le disfunzioni dell’area neuronale coinvolta nei disturbi della gratificazione e dell’umore. La depressione, quindi, non sarebbe conseguenza della patologia, ma un potenziale segnale della sua insorgenza.
La morte dell’area del cervello che produce la dopamina, un neurotrasmettitore essenziale per alcuni importanti meccanismi di comunicazione tra i neuroni, sarebbe la causa dell’Alzheimer. Questa patologia, solo in Italia, colpisce circa mezzo milione di persone oltre i 60 anni di età. La sorprendente scoperta arriva da un’équipe di ricercatori coordinati dal professor Marcello D’Amelio, associato di Fisiologia Umana e Neurofisiologia presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Lo studio, appena pubblicato sulla rivista Nature Communications e al quale hanno collaborato altri scienziati dei laboratori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, della Fondazione IRCCS Santa Lucia e del CNR di Roma, getta una luce nuova su questa grave patologia.
“Abbiamo effettuato un’accurata analisi morfologica del cervello – ha spiega Marcello D’Amelio – e abbiamo scoperto che quando vengono a mancare i neuroni dell’area tegmentale ventrale, che producono la dopamina, il mancato apporto di questo neurotrasmettitore provoca il conseguente malfunzionamento dell’ippocampo, anche se tutte le cellule di quest’ultimo restano intatte”.
Senza la dopamina si perde la memoria
Negli ultimi 20 anni i ricercatori si sono focalizzati sull’area da cui dipendono i meccanismi del ricordo, ritenendo che fosse la progressiva degenerazione delle cellule dell’ippocampo a causare l’Alzheimer. Le analisi sperimentali, tuttavia, non hanno mai fatto registrare al suo interno significativi processi di morte cellulare. Nessun ricercatore aveva finora pensato che potessero essere coinvolte altre aree del cervello nell’insorgenza della patologia. “L’area tegmentale ventrale – ha continuato il professore – non era mai stata approfondita nello studio della malattia di Alzheimer, perché si tratta una parte profonda del sistema nervoso centrale, particolarmente difficile da indagare a livello neuro-radiologico”.
I protagonisti della ricerca sono riusciti a chiarire i dettagli molecolari alla base della mancata comunicazione fra cellule nervose che, nel tempo, porta alla perdita di memoria. I ricercatori si sono resi conto che – come in un effetto domino – la morte delle cellule cerebrali deputate alla produzione di dopamina provoca il mancato arrivo di questa sostanza nell’ippocampo, causandone il ‘tilt’ che genera la perdita di memoria. Lo studio ha evidenziato, già nelle primissime fasi della malattia, la morte progressiva dei soli neuroni dell’area tegmentale ventrale e non di quelli dell’ippocampo. Questo meccanismo è risultato perfettamente coerente con le descrizioni cliniche della patologia di Alzheimer fatte dai neurologi.
La sperimentazione in laboratorio
Un’ulteriore conferma della scoperta è stata possibile somministrando in laboratorio, su modelli animali, due diverse terapie: una con L-Dopa, un amminoacido precursore della dopamina; l’altra basata su un farmaco che ne inibisce la degradazione. In entrambi i casi, dopo aver iniettato il rimedio si è registrato il recupero completo della memoria, in tempi relativamente rapidi.
L’assenza di dopamina influisce anche sul buon umore
“Abbiamo verificato – ha chiarito D’Amelio – che l’area tegmentale ventrale rilascia la dopamina anche nel nucleo accumbens, l’area che controlla la gratificazione e i disturbi dell’umore, garantendone il buon funzionamento. Per cui, con la degenerazione dei neuroni che producono dopamina, aumenta anche il rischio di andare incontro a progressiva perdita di iniziativa, indice di un’alterazione patologica dell’umore”. Questi risultati confermano le osservazioni cliniche secondo cui, fin dalle primissime fasi di sviluppo dell’Alzheimer, accanto agli episodi di perdita di memoria i pazienti riferiscono un calo nell’interesse per le attività della vita, mancanza di appetito e del desiderio di prendersi cura di sé, fino ad arrivare alla depressione.
La depressione è un campanello di allarme
Secondo gli autori della ricerca, i cambiamenti nel tono dell’umore non sarebbero – come si credeva fino ad oggi – una conseguenza della comparsa dell’Alzheimer, ma potrebbero rappresentare piuttosto una sorta di campanello d’allarme dietro il quale si nasconde l’inizio subdolo della patologia. “Perdita di memoria e depressione – ha sottolineato D’Amelio – sono due facce della stessa medaglia”.
Alzheimer e Parkinson: obiettivo comune per la cura
Le prospettive che questo studio schiude sono molteplici. “Il prossimo passo – ha aggiunto il docente che ha coordinato tutta la sperimentazione – dovrà essere la messa a punto di tecniche neuro-radiologiche più efficaci, in grado di farci accedere ai segreti custoditi nell’area tegmentale ventrale, per scoprirne i meccanismi di funzionamento e degenerazione. Inoltre, i risultati ottenuti suggeriscono di non sottovalutare i fenomeni depressivi nella diagnosi di Alzheimer, perché potrebbero andare di pari passo con la perdita della memoria. Infine, poiché anche il Parkinson è causato dalla morte dei neuroni che producono la dopamina, è possibile immaginare che le strategie terapeutiche future per entrambe le malattie potranno concentrarsi su un obiettivo comune: impedire in modo ‘selettivo’ la morte di questi neuroni”.
I dati sperimentali hanno chiarito anche perché i farmaci cosiddetti “inibitori della degradazione della dopamina” – la cui validità terapeutica è stata nel tempo molto discussa – si rivelino utili solo per alcuni pazienti: funzionano unicamente nelle fasi iniziali della malattia, quando ancora sopravvive un buon numero di neuroni dell’area tegmentale ventrale. Con la morte di tutte le cellule di quest’area, la dopamina smette del tutto di essere prodotta e il farmaco, ovviamente, non è più efficace. “L’altra sostanza somministrata in laboratorio nel corso della sperimentazione, chiamata L-Dopa – ha specificato Annalisa Nobili, prima firma dello studio – non può essere data ai pazienti se non nelle ultime fasi della malattia perché, come emerso anche nei casi di Parkinson, provoca fenomeni di particolare tossicità che possono aggravare le loro condizioni”.
Pur essendo, dunque, ancora lontana la validazione di una cura efficace per l’Alzheimer, i risultati della ricerca condotta dal professor D’Amelio e dagli altri partner scientifici aggiungono un tassello decisivo nella comprensione dei meccanismi da cui prende avvio questo temibile morbo. Accorciando, si spera, i tempi che separano la Scienza dal giorno in cui sarà finalmente possibile fermarlo.